Ti guardo con cura.
In quell’unica ora settimanale in cui mi è concesso stare con te e la tua classe.
Mi vedi arrivare, e mi corri incontro, per abbracciarmi, dopo appena 3 ore passate insieme, in 3 diverse settimane.
“Maestra” mi dici entusiasta, e io rispondo “solo Daniela, sai che non ti insegno nulla, io, sei tu che insegni a me con i tuoi giochi in seduta“.
Mi abbracci con tutto te stesso, con veemenza, con il corpo, con le gambe, con le mani che si vorrebbero arrampicare e salire più su, quasi volessi inglobarmi in te.
Rispondo a quel tuo abbraccio, profondo e fugace allo stesso tempo, e poi ti vedo schizzare via.
In quell’abbraccio sento tutta la tua tensione. Mi viene in mente l’immagine di un tubo semirigido con al suo interno una decina di cavi elettrici scoperti. Grossi e neri. Nella sua lunghezza, qualche squarcio, da cui l’elettricità esce.
Senza controllo.
Osservo il tuo colorito, i tuoi bellissimi e profondi occhi scuri che sfuggono, subito concentrati a guardare, a volte senza in realtà vedere, altrove.
Mi sei stato descritto come bimbo difficile, da tenere d’occhio, perchè difficilmente ti fermi e perchè difficilmente fermi le tue mani dal picchiare gli altri compagni.
Come posso non sentirmi chiamare in particolare proprio da te?
Come posso non guardarti di più?
Come posso non percepire il tuo dolore nel crescere?
Quel richiamo che muove dentro, che un po’ duole, perchè a volte ti senti impotente perchè hai finito le strategie, e perchè vorresti comprendere, dare, fare e aiutare di più.
Corri, salti, rimbalzi sui cuscinoni sparsi, li calci lontano, fai il verso del dinosauro, un verso che però ti rimane intrappolato in gola. In quei momenti sei l’animale, non fai finta di farlo. Ma appena esageri con i movimenti, e ti pare di esserti fatto male ad un dito del piede, mi lanci uno sguardo che è richiesta di aiuto.
La tua bocca è una smorfia ma i tuoi occhi mi fanno capire che non ti sei fatto nulla. Di fisico intendo, perchè il dolore, la richiesta che mi invii, parte da un luogo ben profondo.
Arrivo da te piano, guardandoti. Lentamente e con cura ti tolgo il calzino per controllare bene, per occuparmi di te, e nell’assicurarmi che è solo il dito a farti male, tu mi lasci fare, senza mai guardarmi negli occhi. Un delicato massaggio, poi uno più deciso, guardandoti in viso, e un mio dirti “è tutto attaccato“.
Tu non alzi gli occhi, fissi il tuo piede che sto rimettendo nel calzino, un impercettibile movimento dell’angolo della bocca, mi regali un tocco veloce sul braccio e via, di nuovo a correre.
Ricordi il gioco fatto la volta scorsa e inizi ad impilare cuscinoni. Mi avvicino a te, qualche mia parola messa per tracciare una sorta di strada nel tuo pensiero, per darti ritmo e tempo più lento in quel tuo groviglio di cavi elettrici. Si avvicinano i tuoi compagni, in parte perchè mi sto dedicando a te, ma è per entrare in un gioco condiviso.
Ti chiedono se possono giocare, di quali pezzi hai bisogno, come li devono mettere, per far crescere la tua opera.
Capisco bene che non hai un’immagine chiara in mente, ma è lì, la sento che sta per mostrarsi a te. Lo percepisco, nel silenzio di idee che si muovono, e il tuo corpo me lo conferma. E’ più eretto, anche la testa, e ti soffermi più volte ad osservare cosa sta nascendo, con le mani appoggiate sui fianchi.
Scegli un altro pezzo, lo posizioni, lo sistemi, lo scarti, lo rigiri, dai direttive ai tuoi compagni. E tutti ti ascoltano.
In quel momento non c’è bambino straniero, o troppo in movimento, o inibito, o differenza di genere.
Tutti sono dentro al tuo gioco.
Passo dietro di te e ti stringo le spalle in un gesto silenzioso di ammirazione.
Carico di mia emozione.
Ti giri, mi abbracci velocissimo, un abbraccio veloce ma più morbido, e inizi a scalare la tua opera.
Una volta in cima, carponi, mi guardi. Io ho una mano sul quella grande torre, ma il mio corpo è rivolto di lato, per comunicarti fiducia.
Capisci che puoi, e con attenzione ti alzi in piedi.
Lassù, ti guardi riflesso nel grande specchio che hai di fronte, innalzi il braccio destro, rivolgi il viso a chissà quale immensa immagine sopra di te, e chiudi gli occhi.
In quel momento sei grandissimo, felice, carico di emozioni positive, rassicurato e unito.
E l’emozione che ho condiviso con te in quel momento rimarrà indelebile.
La mia esperienza come psicomotricista è breve, ma indubbiamente intensa e mossa da passione.
Spesso penso ad Emma, la mia bambina di 7 anni e mezzo nata con la sindrome di Down, e come questa spinta a conoscere il bambino, sia partita da lei.
Dalla sua diversità che ho poi riconosciuto come unicità.
Emma mi ha stravolto dentro, mi ha permesso di ricostruirmi in una nuova forma, e di osservare lei, Tommaso, e i bambini, con un altro sguardo.
In una sala di psicomotricità il bambino può fare spontaneamente, dire di se liberamente, attraverso il corpo e l’uso del materiale, in una dinamica di relazione empatica con lo psicomotricista.
Ma fuori dalla sala?
Quanto viene comandato, senza lasciare spazio alla sua spontaneità?
Quanta autonomia gli si concede? Dove per autonomia non si intende l’autonomia funzionale, bensì la capacità di organizzarsi, di tenere un progetto, di agire e trasformare.
Quanto ancora si crede educativo punire il troppo movimento con una forzata immobilità, magari facendo saltare la ricreazione agli alunni?
Quanti castighi, lontano dal gruppo, devono utleriormente rinforzare il già presente senso di colpa del bambino?
Quante richieste premature, legate agli apprendimenti, vengono fatte da noi genitori? Richieste per mostrare e mostrarci che sì, anche il nostro bambino è prestante e capace… ma a che prezzo? Quanto orgoglio nel sentire parlare un bambino come un libro stampato… ma quando quel corpo, riavrà la possibilità di muoversi come durante l’infanzia?
Quando e quanto lo si riconosce soggetto, piuttosto che oggetto?











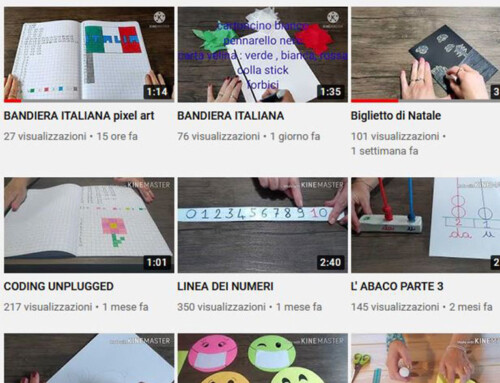
Mi sono commossa nel leggere questo tuo nuovo post; sono riuscita a vedere i suoi occhi, i suoi gesti e, in parte, a vivere le vostre emozioni grazie alla carica emotiva che trapela dalle tue parole…
Complimenti per il lavoro che fai e per come lo fai.